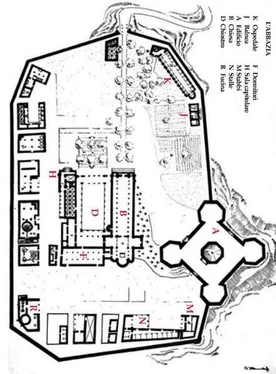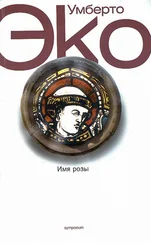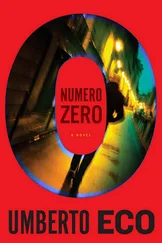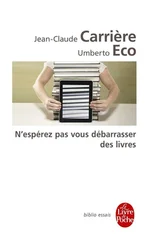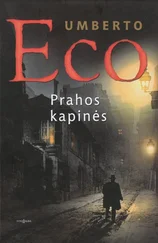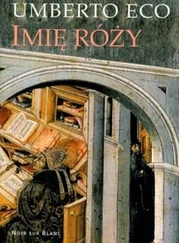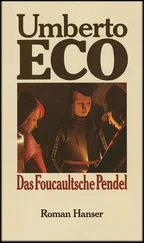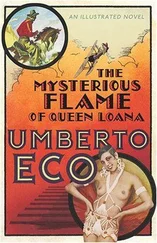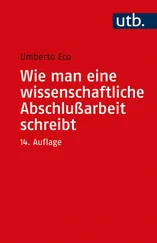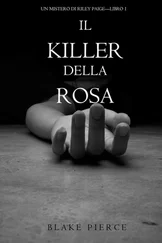L’uomo sorrise (o almeno così credetti) e levando il dito come per ammonire, disse:
“Penitenziagite! Vide quando draco venturus est a rodegarla l’anima tua! La mortz est super nos! Prega che vene lo papa santo a liberar nos a malo de todas le peccata! Ah ah, ve piase ista negromanzia de Domini Nostri Iesu Christi! Et anco jois m’es dols e plazer m’es dolors… Cave el diabolo! Semper m’aguaita in qualche canto per adentarme le carcagna. Ma Salvatore non est insipiens! Bonum monasterium, et aqui se magna et se priega dominum nostrum. Et el resto valet un figo seco. Et amen.No?”
Dovrò, nel prosieguo di questa storia, parlare ancora, e molto, di questa creatura e riferirne i discorsi. Confesso che mi riesce molto difficile farlo perché non saprei dire ora, come non compresi mai allora, che genere di lingua egli parlasse. Non era il latino, in cui ci esprimevamo tra uomini di lettere all’abbazia, non era il volgare di quelle terre, né altro volgare che mai avessi udito. Credo di avere dato una pallida idea del suo modo di parlare riferendo poco sopra (così come me le ricordo) le prime parole che udii da lui. Quando più tardi appresi della sua vita avventurosa e dei vari luoghi in cui era vissuto, senza trovar radici in alcuno, mi resi conto che Salvatore parlava tutte le lingue, e nessuna. Ovvero si era inventata una lingua propria che usava i lacerti delle lingue con cui era entrato in contatto — e una volta pensai che la sua fosse, non la lingua adamica che l’umanità felice aveva parlato, tutti uniti da una sola favella, dalle origini del mondo sino alla Torre di Babele, e nemmeno una delle lingue sorte dopo il funesto evento della loro divisione, ma proprio la lingua babelica del primo giorno dopo il castigo divino, la lingua della confusione primeva. Né d’altra parte potrei chiamare lingua la favella di Salvatore, perché in ogni lingua umana vi sono delle regole e ogni termine significa ad placitum una cosa, secondo una legge che non muta, perché l’uomo non può chiamare il cane una volta cane e una volta gatto, né pronunciare suoni a cui il consenso delle genti non abbia assegnato un senso definito, come accadrebbe a chi dicesse la parola “blitiri”. E tuttavia, bene o male, io capivo cosa Salvatore volesse intendere, e così gli altri. Segno che egli parlava non una, ma tutte le lingue, nessuna nel modo giusto, prendendo le sue parole ora dall’una ora dall’altra. Mi avvidi pure in seguito che egli poteva nominare una cosa ora in latino ora in provenzale, e mi resi conto che, più che inventare le proprie frasi, egli usava disiecta membra di altre frasi, udite un giorno, a seconda della situazione e delle cose che voleva dire, come se riuscisse a parlare di un cibo, intendo, solo con le parole delle genti presso cui aveva mangiato quel cibo, ed esprimere la sua gioia solo con sentenze che aveva udito emettere da gente gioiosa, il giorno che egli aveva provato parimenti gioia. Era come se la sua favella fosse quale la sua faccia, messa insieme con pezzi di facce altrui, o come vidi talora dei preziosi reliquiari (si licet magnis componere parva, o alle cose divine le diaboliche) che nascevano dai detriti di altri oggetti sacri. In quel momento, in cui lo incontrai per la prima volta, Salvatore mi apparve, e per il volto, e per il modo di parlare, un essere non dissimile dagli incroci pelosi e ungulati che avevo appena visto sotto il portale. Più tardi mi accorsi che l’uomo era forse di buon cuore e di umore faceto. Più tardi ancora… Ma andiamo per ordine. Anche perché, non appena egli ebbe parlato, il mio maestro lo interrogò con molta curiosità.
“Perché hai detto penitenziagite?” chiese.
“Domine frate magnificentisimo,” rispose Salvatore con una sorta di inchino, “Jesus venturus est et li homini debent facere penitentia. No?”
Guglielmo lo guardò fissamente: “Sei venuto qui da un convento di minoriti?”
“No intendo.”
“Chiedo se sei vissuto tra i frati di santo Francesco, chiedo se hai conosciuto i cosiddetti apostoli…”
Salvatore impallidì, ovvero il suo volto abbronzato e belluino divenne grigio. Fece un profondo inchino, pronunciò a mezze labbra un “vade retro”, si segnò devotamente e fuggì voltandosi indietro ogni tanto.
“Cosa gli avete chiesto?” domandai a Guglielmo.
Egli restò un poco soprappensiero. “Non importa, te lo dirò dopo. Ora entriamo. Voglio trovare Ubertino.”
Era da poco trascorsa l’ora sesta. Il sole, pallido, penetrava da occidente, e quindi da poche e sottili finestre, nell’interno della chiesa. Una striscia sottile di luce toccava ancora l’altare maggiore, il cui paliotto mi parve rilucere di un fulgore aureo. Le navate laterali erano immerse nella penombra.
Presso all’ultima cappella prima dell’altare, nella navata di sinistra, si ergeva una esile colonna su cui stava una Vergine in pietra, scolpita nello stile dei moderni, dal sorriso ineffabile, il ventre prominente, il bambino in braccio, vestita di un abito grazioso, con un sottile corsetto. Ai piedi della Vergine, in preghiera, quasi prostrato, stava un uomo, vestito con gli abiti dell’ordine cluniacense.
Ci appressammo. L’uomo, udendo il rumore dei nostri passi, alzò il volto. Era un vegliardo, col volto glabro, il cranio senza capelli, i grandi occhi celesti, una bocca sottile e rossa, la pelle candida, il teschio ossuto a cui la pelle aderiva come fosse una mummia conservata nel latte. Le mani erano bianche, dalle dita lunghe e sottili. Sembrava una fanciulla avvizzita da una morte precoce. Posò su di noi uno sguardo dapprima smarrito, come lo avessimo disturbato in una visione estatica, poi il volto gli si illuminò di gioia.
“Guglielmo!” esclamò. “Fratello mio carissimo!” Si alzò a fatica e si fece incontro al mio maestro, abbracciandolo e baciandolo sulla bocca. “Guglielmo!” ripeté, e gli occhi gli si inumidirono di pianto. “Quanto tempo! Ma ti riconosco ancora! Quanto tempo, quante vicende! Quante prove che il Signore ci ha imposto!” Pianse. Guglielmo gli rese l’abbraccio, evidentemente commosso. Ci trovavamo davanti a Ubertino da Casale.
Di lui avevo già sentito parlare e a lungo, anche prima di venire in Italia, e ancor più frequentando i francescani della corte imperiale. Qualcuno mi aveva persino detto che il più grande poeta di quei tempi, Dante Alighieri da Firenze, morto da pochi anni, aveva composto un poema (che io non potei leggere perché era scritto nel volgare toscano) a cui avevano posto mano e cielo e terra, e di cui molti versi altro non erano che una parafrasi di brani scritti da Ubertino nel suo Arbor vitae crucifixae . Né questo era il solo titolo di merito di quell’uomo famoso. Ma per permettere al mio lettore di capire meglio l’importanza di quell’incontro, dovrò cercare di ricostruire le vicende di quegli anni, così come le avevo comprese e durante il mio breve soggiorno nell’Italia centrale, da parole sparse del mio maestro, e ascoltando i molti colloqui che Guglielmo aveva avuto con abati e monaci nel corso del nostro viaggio.
Cercherò di dirne cosa avevo capito, anche se non son sicuro di dire bene queste cose. I miei maestri di Melk mi avevano detto sovente che è molto difficile per un nordico farsi idee chiare sulle vicende religiose e politiche d’Italia.
La penisola, in cui la potenza del clero era evidente più che in ogni altro paese, e in cui più che in ogni altro paese il clero ostentava potenza e ricchezza, aveva generato da almeno due secoli movimenti di uomini intesi a una vita più povera, in polemica coi preti corrotti, di cui rifiutavano persino i sacramenti, riunendosi in comunità autonome, al tempo stesso invise ai signori, all’impero e alle magistrature cittadine.
Infine era venuto santo Francesco, e aveva diffuso un amore di povertà che non contraddiceva ai precetti della chiesa, e per opera sua la chiesa aveva accolto il richiamo alla severità dei costumi di quegli antichi movimenti e li aveva purificati dagli elementi di disordine che si annidavano in essi. Avrebbe dovuto seguirne un’epoca di mitezza e santità, ma, come l’ordine francescano cresceva e attirava a sé gli uomini migliori, esso diveniva troppo potente e legato ad affari terreni, e molti francescani vollero riportarlo alla purezza di un tempo. Cosa assai difficile per un ordine che ai tempi in cui ero all’abbazia già contava più di trentamila membri sparsi in tutto il mondo. Ma così è, e molti di questi frati di san Francesco si opponevano alla regola che l’ordine si era data, dicendo che l’ordine aveva ormai assunto i modi di quelle istituzioni ecclesiastiche per riformare le quali era nato. E che questo era già avvenuto ai tempi in cui Francesco era in vita, e che le sue parole e i suoi propositi erano stati traditi. Molti di essi riscoprirono allora il libro di un monaco cistercense che aveva scritto agli inizi del XII secolo dell’era nostra, chiamato Gioacchino e a cui si attribuiva spirito di profezia. Infatti egli aveva previsto l’avvento di un’era nuova, in cui lo spirito di Cristo, da tempo corrotto a opera dei suoi falsi apostoli, si sarebbe di nuovo realizzato sulla terra. E aveva annunciato tali scadenze che a tutti era parso chiaro che egli parlasse senza saperlo dell’ordine francescano. E di questo molti francescani si erano assai rallegrati, pare sin troppo, tanto che a metà secolo a Parigi i dottori della Sorbona condannarono le proposizioni di quell’abate Gioacchino, ma pare che lo fecero perché i francescani (e i domenicani) stavano diventando troppo potenti, e sapienti, nell’università di Francia, e si voleva eliminarli come eretici. Il che poi non si fece e fu un gran bene per la chiesa, perché ciò permise che fossero divulgate le opere di Tommaso d’Aquino e di Bonaventura da Bagnoregio, che certo non erano eretici. Dove si vede che anche a Parigi le idee erano confuse, o qualcuno voleva confonderle per fini suoi. E questo è il male che l’eresia fa al popolo cristiano, che rende oscure le idee e spinge tutti a diventare inquisitori per il proprio bene personale. Che poi quanto vidi all’abbazia (e di cui dirò dopo) mi ha fatto pensare che spesso sono gli inquisitori a creare gli eretici. E non solo nel senso che se li figurano quando non ci sono, ma che reprimono con tanta veemenza la tabe eretica da spingere molti a farsene partecipi, in odio a loro. Davvero, un circolo immaginato dal demonio, che Dio ci salvi.
Читать дальше