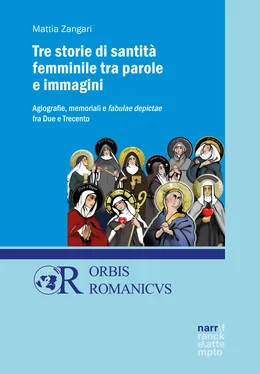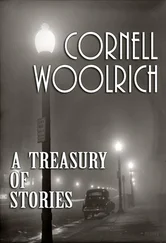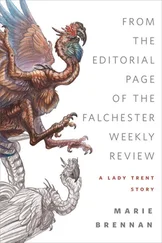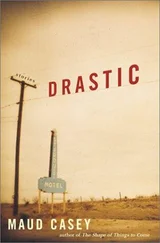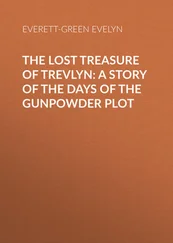Il valore della Vita è inoltre strettamente legato a finalità soteriologiche perché Lutgarda, specchio di tutte le monache, è compartecipe all’azione redentrice:
La Vita Lutgardis rappresenta una tappa fondamentale nella storia dell’autocoscienza cristiana, perché la mistica di Aywières vive nella consapevolezza del valore costruttivo e dell’energia spirituale della sofferenza quando essa viene offerta nel segno della croce. Abitando nel cuore di Cristo, tutta raccolta nelle sue piaghe gloriose, Lutgarda partecipa all’opera di redenzione del mondo.7
Profetessa di principesse e castellane,8 unica interlocutrice del fantasma di Maria di Roavia,9 ammonitrice di sacerdoti, essendo dotata di grazia nel linguaggio,10 la monaca Lutgarda di Aywières, come dicevamo, è l’ultima delle quattro matres di cui Tommaso di Cantimpré ci trasmette la biografia. Benedettina originaria di Tongeren, nelle Fiandre, era passata all’età di ventiquattro anni (intorno al 1205) al Cistercio di Aywières, in Brabante, nella diocesi di Liegi. La mistica, dotata di xenoglossia, infaticabile quanto a tenacia nelle lunghe e severe astinenze, è presentata da Tommaso, nel libro secondo, una volta eletta priora (II, 20), essendo lei la candela più splendente del monastero, come fosse un candelabro, una candela posta sulla sommità del candelabrum «poiché non era giusto che una lucerna tanto grande fosse di lato sotto il moggio»:
Præterea, quoniam tantam lucernam latere sub modio non decebat, posita est super candelabrum; ut fulgor gratiæ eius omnibus appareret. Præposita ergo, id est priorissa ancillarum Dei in monasterio S. Catharinæ uno omnium consensu electa est, et concessa: abbatissam enim habere in ipso monasterio non solebant.11
Quando nel 1246, il sedici di giugno, la santa madre Lutgarda si addormenta per sempre nel catafalco custodito dalle cistercensi del monastero di Aywières, il suo corpo risplende col candore dei gigli, la sua pelle è come di bisso al tatto di chi la palpa, gli occhi spalancati, vitrei, ritti verso il cielo, quasi fosse una bambola di cera:
Proinde proprium ex natura morientium est, ut in morte livido pallore nigrescant: pia autem Lutgardis, in signum innocentiæ virginalis, candorem in morte cum nitore lilii in facie prætendebat. Oculos in cælum (ut dictum est) instante hora mortis diu ante clausos aperuit, nec eos postea in morte vel post mortem reclusos habere potuit: quia ipse oculorum gestus, iter, per quod transierat spiritus, indicavit. Cutis autem totius corporis eius tantæ lenitatis a contrectantibus est reperta, ut sub palpantis manu byssus pariter candens et lenis plenissime crederetur: nemirum simplex hæc sine felle columba, lotos lacte puritatis oculos habuit, quæ speculabatur residens iuxta fluenta plenissima.12
Questa scena in cui è descritta la monaca esanime è arricchita dalla composizione di alcuni versi, nello stile di un epitaffio, versi composti dalla fedele compagna di Lutgarda, Sibilla de Gagis, i quali avrebbero costituito il ricordo della defunta, apposti nel lato destro del coro del convento di Aywières, il lato in cui la morta era solita pregare:
Lutgardis luxit; vitam sine crimine duxit; [cum epitaphio]
Cum Christo degit, quam lapis iste tegit.
Esuriens hæc et sitiens cælestia, luxit;
Mera dies, sponsi facies, illi modo luxit.
Hæc speculum vitæ, flos claustri, gemma sororum;
Fulsit in hac pietas, compassio, gloria morum.13
Da notare la triplice anafora del verbo luceo («luxit», brillò), ripresa nell’ultimo verso da «fulsit». Oltre ad alcune rime interne, che danno forse luogo a un insieme stilisticamente un po’ goffo («luxit» – «duxit» v. 1, «degit» – «tetigit» v. 2, «esuriens» – «sitiens» v. 3, «dies» – «facies» v. 4), riluce al v. 5 l’espressione «speculum vitae», riferito al valore dell’esemplarità della vita in cui rispecchiarsi.
Le sequenze qui riportate hanno tutti crismi di frammenti polinodali: hanno un impianto agiografico, quindi didascalico, ma presentano in pari tempo finalità soteriologiche ed elementi di raccordo rispetto ad altri testi coevi, testi di monache e beghine vissute tra le Fiandre e il Brabante, ma pure di religiosae mulieres tedesche e, come già segnalava Romana Guarnieri, forti tangenze nei confronti delle Vitae delle bizzoche del Centritalia.14 Tommaso di Cantimpré scrive la vita di Lutgarda e più in generale queste Vitae matrum prendendo coscienza progressivamente del valore di queste mulieres , del tracciato descritto dal vissuto di tutte loro le quali pur vivendo ai margini dell’istituzione ecclesiale e del contesto sociale, divengono exempla .15 Sono opere enciclopediche, arazzi densi di informazioni estremamente preziose per ricostruire l’ambiente del tempo, dai menologi dei benedettini, dei cistercensi e delle spiritualità cui i reclusori beghinali erano legati, via via sino alle finalità propagandistiche con le quali queste donne divengono i simulacri di un culto che va impresso e trasmesso, attraverso i testi e le immagini.
Da Tommaso a Baro le Roy: stile del testo, codici manoscritti e edizioni a stampa
Non è affatto facile presentare uno status quaestionis sulla Vita Lutgardis , mai editata e, in un certo senso, ancora «sepolta» nella congerie degli Acta Sanctorum . Si cercherà di delineare qui un quadro filologico in base a una lettura del testo che prenderà le mosse dal Commentarius praevius , da questo «libretto d’istruzioni» introduttivo da sottoporre a un’analisi, a mo’ di tabula orientativa.
Anzitutto il Commentario preliminare ci dà notizia di come la memoria di santa Lutgarda, vergine brabantina, sia inserita nel sedici di giugno all’interno del Martirologio romano , in base alle indicazioni del manoscritto Florario e di altri manoscritti redatti ad uso delle chiese belghe.1
Il testo degli Acta Sanctorum , quello su cui lavoreremo noi, non è tuttavia l’unico ad aver trasmesso l’agiografia di Lutgarda perché, sebbene con molteplici omissioni, già Lorenzo Surio (1522-1578), dopo averlo emendato (essendo per lui eccessivamente «simplex»),2 ne pubblica una, di cui non si ha traccia; tornando al testo degli Acta , fondamentale è capire quali siano i codici alla base del nostro scritto d’appoggio, vale a dire: l’autorevole codice del Collegio di Bruges, il manoscritto presente nella Biblioteca dei Canonici Regolari nella Valle Rubea, nei pressi di Bruxelles, e infine un ultimo codice vagliato da Alberto Mireo.3
Il nostro testo presenta un’impostazione di forte connotazione storica, alla quale è quasi totalmente sacrificata l’eleganza formale. Non sussistono infatti molte elaborazioni retoriche, né particolari artifici letterari, volendo rispondere prevalentemente a obiettivi di veridicità.
L’opera sistematizzata dai Bollandisti si presenta con un numero progressivo di colonna, inserito tra parentesi quadre, e molte annotazioni interpolate e segnalate da simili parentesi, probabilmente opera di Giovanni Molano (†1585), sommari o commenti parziali, ma sistematici.4 Vi sono inoltre delle note erudite, di carattere tecnico, talvolta esplicativo, e viene data una scansione in capitoli titolati. Dopodiché è data un’informazione preliminare sull’autore, e quindi il passaggio dai Canonici Regolari all’Ordine dei Predicatori, le lodi alla nobiltà d’animo, alla rettitudine morale e l’ammirazione palesata da noti personaggi, tra i quali ricordiamo Roberto Bellarmino e Giusto Lipsio.5 Infine, in III, 19-20, quindi a conclusione della storia, veniamo a sapere come non soltanto la vicenda qui trascritta da Tommaso sia un modo per rendere grazie alla Santa cui era ed è devoto, ma una forma attraverso la quale pagare tributo alla badessa Hadeweijch, che gli aveva promesso in cambio, come reliquia, la mano della cisterciense fiamminga.
Читать дальше