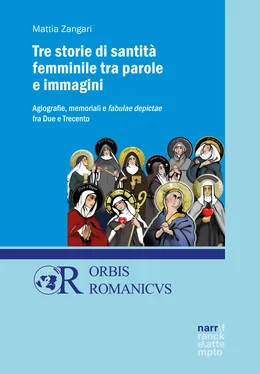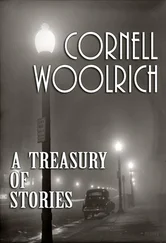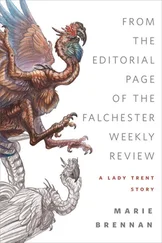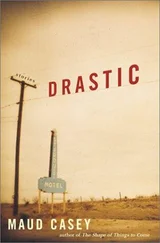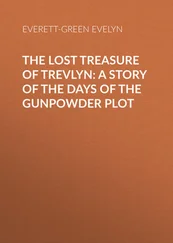Tunc coepit Christina agere illa, propter quae a Domino remissa fuerat. Ingrediebaturque clibanos ignivomos, ad coquendum panes paratos, cruciabaturque incendiis velut aliquis nostrum, ita ut horrifice clamaret prae angustia, nec tamen in egredientis corpore laesura forinsecus apparebat. […] Sub aquis Mosae fluminis glaciali tempore frequenter ac diutius morabatur, adeo ut in iis, sex diebus et eo amplius permaneret. […] In hyeme etiam sub rota molendini ibat erecta stare, ita quod aqua dilaberetur per medium caput et membra eius. Veniebat etiam cum aqua natans aliquando, cadebatque cum aqua super rotae circuitum, nec ulla laesura tamen apparebat in membris. In rotis etiam, in quibus piratae aliquando cruciari solebant, more tortorum flectebat cura et brachia sua, et tamen, cum descenderet, non apparebat fractura in membris suis. Ibat etiam ad patibulum, et se inter latrones suspensos laqueo suspendebat, ibique uno die vel duobus suspensa pendebat. Saepiusque quoque sepulchra mortuorum intrabat, plangebatque ibi peccata hominum. Media etiam nocte quandoque surgebat, et canes totius civitatis S. Trudonis provocans ad latratus, quasi bestia fugiens praecurrebat, insequebanturque eam canes, et per silvas atque condensa spinarum agitabant eam, ita ut nulla pars corporis eius a plaga remaneret immunis, et tamen cum sanguinem diluisset, nullum laesurae vestigium apparebat.14
Pare esserci una coscienza comune della dimensione patologica del comportamento della mistica Cristina, tanto che le sorelle e gli amici pensano sia posseduta dagli spiriti maligni; inoltre la donna respinge la morale comune perché mangia in casa dei ladri e degli assassini, dividendo con loro il pane dei furti (II, 23).15 Segnaliamo anche un’affinità rispetto alla mistica Angela da Foligno: come Angela, Cristina beve l’acqua contaminata dalla lebbra:
Et postquam ista optulimus eis, lavimus pedes feminarum et lavimus manus hominum, maxime cuiusdam leprosi qui habebat manus valde fracidas vel marcias et perditas, et bibimus de illa lotura. Et tantam dulcedinem sensimus, quod per totam viam venimus in magna suavitate ac si communicavissemus. Et videbatur michi recte quod ego comunicassem, quia suavitatem maximam sentiebam sicut si comunicassem, quia suavitatem. Et quia quedam scarpula illarum plagarum erat interposita in gutture, ego conabar ad glutiendum eam et reprehendebat me coscientia expuere sicut si comunicassem, quamvis non expuerem ed eiciendum, sed ad deponendum eam de gutture.16
Il vero protagonista dell’opera, ha notato Alessandra Bartolomei Romagnoli, sembra essere però il corpo di questa reclusa dei boschi, un corpo che si fa docile strumento dell’anima e suo prigioniero, e si assiste infatti a veri e propri dialoghi fra l’anima e il corpo:
Et tamen cum iniuste aliquid acquisitum, et sibi in elemosynam datum comederet, videbatur ei quod ranarum ac bufonum viscera aut intestina serpentium deglutiret. Unde in esu talium clamabat quasi parturiens: «O Christe, quod agis mecum? Sic quare me crucias?»; tundensque pectus et corpus, dicebat: «O anima misera, quid desideras? Quid concupiscis haec orrida? Cur iis soridibus vesceris?».17
La Vita di Margherita d’Ypres – e veniamo alla terza delle Vitae matrum – è un modello parenetico pensato perché i domenicani si dedichino alla cura degli animi femminili; Sigieri (il padre spirituale della fanciulla) distoglie infatti Margherita dal proposito del matrimonio e la poverina acconsente, dedicando la propria verginità a Dio, donandosi a un tipo di vita che non è né monastico né strettamente beghinale. La ragazza trascorre il resto della propria vita in famiglia, assorta nella contemplazione, docile e virtuosa, mentre i parenti cercano di distoglierla da questo suo strano proposito di nubilato, da queste pratiche oranti che la portano a rifuggire da ogni distrazione mondana, rendendola completamente svanita. Un giorno compare sul suo braccio una stella, di cui la madre non capisce il significato:
De eo quod stella apparuit in humero eius
Sedens aliquando cum matre sua et sorore illius, sua matertera, de Deo invicem conferebant. Nec mora. In momento stelle clarissime lux visa est in humero Margarete et cum mater obstupefacta exclamaret: «Quid est hoc, filia?», respondit: «Non paveas, mater, quoniam Dominus in medio nostri est», et hoc secundum illud, quod olim dixerat Dominus: Ubi duo vel tres congregati fuerint in nomine meo, in medio eorum sum (Mt 18, 20).18
Un’altra funzione assolta da questa biografia, data l’iniziale infatuazione della giovinetta nei confronti di un pretendente, è dimostrare come, anche per le anime sante, sia difficile smarcarsi dalle seduzioni terrene. Quello che qui ci interessa porre in risalto è poi il legame di Margherita con le immagini: sin da bambina comincia a flagellarsi, dopo aver visto in chiesa la figura di Cristo crocifisso;19 racconta a Sigieri un sogno in cui Gesù le appare con tre corone d’oro – a lei ne consegna una «pro voto castitatis», le altre due, dice Cristo, saranno consegnate alle sue sorelle, ma queste dovranno meritarsele:
Sompniavi, inquit, si tamen somnium vocari debet, ignoro, quia nunquam vel in seculo posita in sermone aut ecclesia dormitavi. Illa hoc dicens necdum cognoverat Dominum, nec umquam ei fuerat revelatum. Cui idem spiritualis pater eius ridendo respondit: Quid, inquit, filia sompniasti? – Vidi, ait, quasi in sompniis, sed, ut cortissime scio, evidentius tamen, vidi, inquam, lucidissime Dominum meum Iesum Christum, cum tribus michi aureis coronis astare et unam capiti meo imponens dixit: Hanc tibi, filia, pro voto, quod michi feristi, confero castitatis; reliquas duas sororibus tuis, si tecum perseveraverint, repromitto. Quo audito, ille spiritualis pater eius in Domino ex totis visceribus exultavit, animadvertens et videns, quod Deus sua gracia iuvenculam visitasset et quod acceptus ei iam esset fructus, quem in novella planta efficaci sermone rigaverat.20
Lutgarda: storia di una monaca
Come le altre tre agio-biografie, la Vita Lutgardis , che analizzeremo tra poco, sembra risentire molto dell’idea di santità che sottostà al modello femminile paolino. Le pagine di san Paolo dedicate alla santità non intendono, come sappiamo, quella costituita «populi credentis intuitu», stabilita dai processi istituzionali, dagli albi e dai codici; la santità della «letteratura» paolina fa fede alla testimonianza oculare e riguarda la condotta di chi, come le madri di Tommaso di Cantimpré, sta spesso ai margini della società.1 Lutgarda (come le altre protagoniste delle Vitae matrum ) non è una nobile regina altomedievale di cui ci si appresta a trascrivere vita e miracoli,2 si tratta di una donna «normale», come nel caso «dei santi paolini, uomini e donne, ai quali il linguaggio apostolico di Paolo e della sua cerchia assegna originariamente questo attributo di aghios nella ferialità silenziosa o anche dimenticata della loro vita».3 Indagando le parole del Santo, ci si imbatte in quei famosi «divieti» imposti alle donne, veti che si rievocano qui per il motivo che stiamo per vedere. Paolo aveva affermato:
Come in tutte le comunità dei santi, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la Legge. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea ( 1 Cor 14, 33-35).
Queste stesse inibizioni sancite da san Paolo avrebbero fatto da punto d’appoggio ideologico alla Periculoso , la bolla di Bonifacio VIII risalente al 1298, con la quale sarebbe stata imposta la vita claustrale al «sottobosco» europeo di cellanae , reclusae , bizzoche e beghine che, al di fuori di una precisa identità istituzionale, vivevano presso municipi, palazzi, ponti, cattedrali, ma pure nelle foreste e nei dirupi, presso gli ospizi, gli eremi e le curie.4 Lutgarda rappresenta, già si anticipava, lo specchio delle virtù monastiche, la monaca da emulare e ricordare per la sua sottomissione e la sua obbedienza, sotto le quali giace tuttavia il potere della preghiera d’intercessione (così come nel caso delle donne delle quali si parla in 1 Cor 11,5)5 e in tal senso si può forse affermare che testi come la Vita Lutgardis preparano il terreno alla costituzione bonifaciana.6
Читать дальше