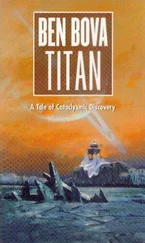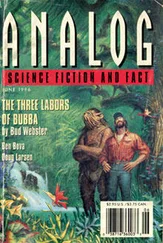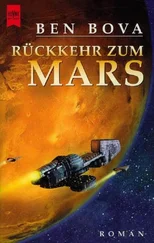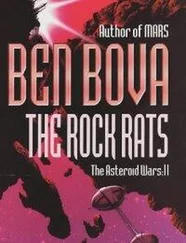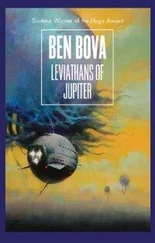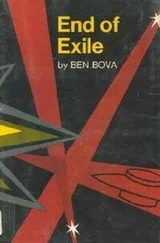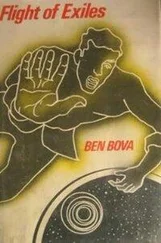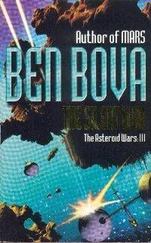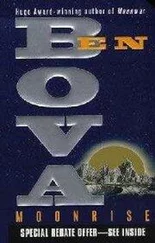«Gesù Cristo» mormorò Stoner. «Gratta un russo, e sotto la pelle scoprirai il filosofo.»
«Sì» disse Markov. «Un filosofo molto religioso, se è per questo. Però tienilo a mente, amico mio. Questo visitatore alieno ci farà sentire tutti molto più vicini.»
«Spero che tu abbia ragione, Kirill.»
«L’ha già fatto! Ci ha fatto diventare amici, no?»
Stoner annuì.
«Un’amicizia molto bella, Keith.» Gli occhi di Stoner s’inumidirono.
«Sono molto fiero di averti come amico, Keith Stoner. Tu sei un brav’uomo. Se fosse necessario, darei la mia vita per te.»
Per diversi momenti, Stoner non seppe cosa rispondere. «Ehi, Kirill, questo lo penso anch’io. Ma non siamo alla fine della nostra amicizia. Siamo solo all’inizio.»
«Lo spero» sospirò Markov. «Quando atterreremo, però, né tu né io saremo più padroni al cento per cento delle nostre vite. Gli eventi ci trascineranno a loro piacimento. Ed è molto probabile che io non possa lasciare mai più la Russia, per rivedere te o altri stranieri.»
L’idea colse Stoner alla sprovvista. Sorpreso, si sentì ribattere: «E io potrei anche non tornare dalla missione di rendez-vous.»
«Ah, non avevo nemmeno pensato a questa eventualità.»
Stoner trasse un profondo respiro.
«Però posso prometterti una cosa» disse Markov, prima che Stoner riuscisse a formulare una risposta.
«E cioè?»
«Tu partirai. Nessuno ti fermerà a terra. Questo te lo prometto.»
Stoner annuì, e sorrise, e si disse: “Parla sul serio, ma non ha modo di tenere fede alla promessa”.
Markov imbastì un sorriso, gli occhi ancora umidi, e senza un’altra parola tornò al suo sedile.
Stoner riportò gli occhi sulla steppa, e dopo un po’ si addormentò. Lo risvegliò all’improvviso un sobbalzo dell’aereo, e il rumore del carrello d’atterraggio che scendeva. L’aereo continuò a sobbalzare in modo atroce. A un certo punto, parve che il terreno erboso si alzasse a inghiottirli.
La cabina era come scossa da una tempesta. Allacciandosi la cintura di sicurezza, Stoner vide che Zworkin adesso era perfettamente sveglio, che stringeva spasmodicamente i braccioli del sedile.
Poi l’aereo smise di rollare, scese fra le prime ombre del tramonto sulla pista d’atterraggio. Stoner guardò fuori dal finestrino e restò a bocca spalancata.
Tyuratam.
Sembrava il paesaggio di Manhattan, con l’unica differenza che lì non c’erano grattacieli, ma torri di lancio. Strutture d’acciaio per ospitare e far partire missili. Per chilometri e chilometri! Una dopo l’altra, un’intera città fatta di torri di lancio. Al confronto, Cape Canaveral sembrava una modesta periferia, di dimensioni minime e poco solida. Quel posto, invece, era destinato a durare per l’eternità. Come Pittsburgh, come Gary, come le distese interminabili di fabbriche nei maggiori centri industriali. Tyuratam era un complesso massiccio, operoso di edifici giganteschi, grandi macchine, e persone instancabili.
Il loro mestiere era lanciare razzi. Il loro lavoro era l’astronautica. Sì, quello era un vero porto, come la favolosa Basra delle Notti d’Arabia , come Marsiglia o New York o Shanghai. Da quel porto, su lunghe lingue di fiamma, partivano navi dirette nello spazio, e tornando riportavano tesori di nuove conoscenze.
“E un giorno o l’altro” rifletté Stoner “riporteranno energia, e materie prime, e si comincerà a costruire fabbriche in orbita.”
Per adesso, però, sondavano i mari ignoti dello spazio per conoscere di più, per individuare le orbite più sicure per i satelliti che dovevano ritrasmettere le informazioni a terra.
L’aereo si abbassò. Stoner vide le luci che circondavano una piattaforma di lancio, dove un razzo argenteo era immobile nella morsa di una torre scintillante.
Una torre di lancio per Soyuz, comprese. “Io volerò su quel missile.”
Non notò, sul lato opposto del grande complesso di torri e razzi, due altri missili allineati fianco a fianco. Erano dipinti di verde, e avevano testate capaci di seminare molti megaton di morte.
O siamo soli nell’universo, o non lo siamo. Entrambe le prospettive sono sconvolgenti.
Lee Dubridge
Stoner era chino sul foglio di carta, incerto, la penna in mano. Fino a quel momento aveva scritto:
Mr. Douglas Stoner
28 Rainbow Way
Palo Alto, CA 94302
Caro figlio,
come stai? Se hai seguito i notiziari, saprai probabilmente che mi trovo in Russia, e che sto per intraprendere una missione spaziale per andare incontro alla nave aliena, ammesso che ciò sia possibile. I russi ci trattano molto bene. Ci hanno sistemati in una specie di caserma, no, anzi, sembra più un collegio. Ognuno ha una stanzetta, ma io non passo molto tempo nella mia.
Nelle ultime settimane, ho lavorato sodo con i cosmonauti russi e coi tecnici addetti al lancio. Avresti dovuto vederli quando hanno cercato d’infilarmi in una delle loro tute! Io sono più alto e magro dei loro cosmonauti, e hanno dovuto modificare la tuta molto in fretta. E ho sempre avuto addosso i loro medici. C’era da pensare che fossi io l’alieno, con tutti gli esami che mi hanno fatto!
Tutti sono stati molto gentili con noi, anche se non possiamo allontanarci dai dormitori e dai pochi altri edifici dove abbiamo lavorato. Ai russi non va che noi ficcanasiamo in giro. Immagino che anche noi saremmo altrettanto prudenti, se avessimo ospiti stranieri al centro spaziale di Cape Kennedy, in Florida.
Qui ci sono altri undici scienziati stranieri, oltre a
Rimise giù la penna. “Cosa importa?” si chiese. “A Doug non interessa.”
E cosa diavolo interessa a Doug? D’improvviso, capì di non conoscere suo figlio. Il ragazzo era per lui un perfetto sconosciuto. E sapeva ancora meno della figlia più giovane.
Con uno sbuffo di disgusto sbatté la penna sul tavolo di legno, si alzò, raggiunse la porta, percorse lentamente il corridoio. Tutte le altre porte erano chiuse. Non era ancora tardi; la cena era terminata meno di un’ora prima.
“Però domani è il grande giorno” si disse Stoner. Il conto alla rovescia. Il lancio.
Tutto sembrava innaturalmente calmo. In America, tutto era più vivace, più vivo. C’erano sempre riunioni, conferenze stampa, incontri anche a notte fonda, fotografi che abbagliavano coi lampi dei flash.
Ma non qui. Niente giornalisti. Nessun fotografo.
Scese nella stanza dove mangiavano tutti assieme, Uno dei fisici cinesi sedeva sulla poltrona di pelle in un angolo; alla luce di una lampada, leggeva un libro in russo. Stoner fece un cenno, e il cinese rispose con un sorriso. L’interprete era scomparso; non potevano chiacchierare.
Stoner studiò il tavolo rotondo al centro della stanza, fissò irrequieto gli scaffali quasi vuoti di libri, s’incamminò verso la porta della cucina, l’aprì.
Markov era chino sul frigorifero aperto, probabilmente in cerca di cibo.
«Hai preso due razioni di dessert» disse Stoner.
Markov alzò la testa. «E con ciò? Mi tieni sotto controllo? Be’, non posso farci niente. Quando sono nervoso, mangio. È per non far abbassare il tasso degli zuccheri nel sangue.»
«La baklava era ottima» ammise Stoner. «Se non altro, qui la cucina è di alta classe.»
«Ne vuoi un po’? Se ne è rimasto.»
«No.» Stoner scosse la testa. «Quando sono nervoso, io non riesco a mangiare.»
Markov lo fissò. «Nervoso, tu? Sembri così calmo, così rilassato.»
«Dentro sono tutto un tremito.»
Con un sospiro di delusione, Markov chiuse il frigorifero. «Il dolce è finito. Strano, avrei giurato che ne fosse rimasto un po’.»
Tornarono nell’altra stanza. Il fisico cinese era scomparso, ma uno dei russi si era accomodato in poltrona e aveva acceso la radio. Una melodia classica per pianoforte risuonava nella stanza.
Читать дальше