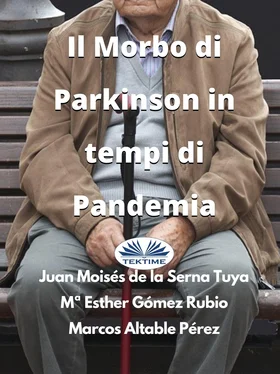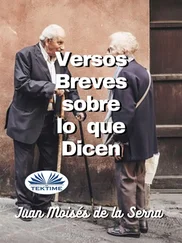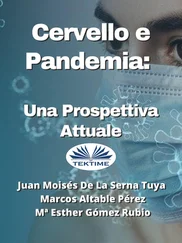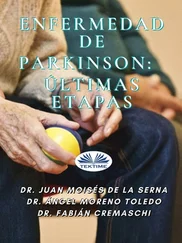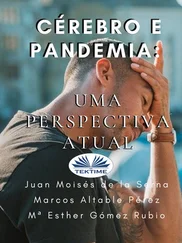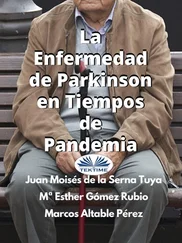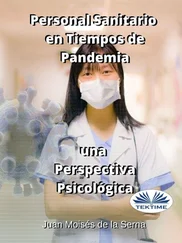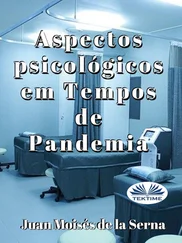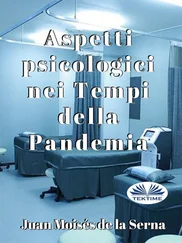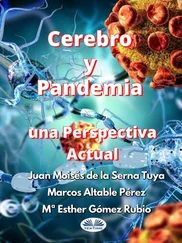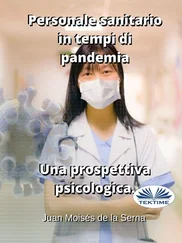Un esempio di questa modifica è quando abbiamo eseguito degli esercizi ginnici senza il riscaldamento preliminare appropriato, che possono provocare dei crampi nelle ore successive all’attività fisica.
Allo stesso modo, l’esercizio eccessivo di un gruppo di muscoli può renderli temporaneamente “flosci” e flaccidi, recuperando il loro “tono” muscolare dopo poche ore.
Tenendo conto che i muscoli distribuiti in tutto il corpo permettono alla persona di eseguire movimenti grazie alla loro capacità di contrarre e rilassare i tessuti che li compongono.
Tutto questo “guidato” dal sistema nervoso centrale, che impartisce gli ordini che consentono di eseguire i movimenti in modo coordinato.
Basti pensare a tutti i gruppi muscolari coinvolti nella deambulazione e che senza un “piano” prestabilito sarebbe difficile, se non addirittura impossibile, riuscire a deambulare “armoniosamente”.
Tornando alla distonia, quando è cronica, si chiama sindrome distonica, dove la tonalità dei muscoli è alterata, totalmente o parzialmente, solitamente associata a cause genetiche o a un trauma cranico, che può essere espresso con perdita di forza nei muscoli, crampi, spasmi involontari, tremori e incoordinazione dei movimenti, accompagnati in alcuni casi da dolore.
Oltre ai segni, tra i sintomi ci sono irrequietezza nei movimenti, tentativo di nascondere mani e piedi, frequenti schiarimenti della gola, dovuti al cambio di tono della voce, tutti fattori che porteranno ad esaurimento fisico e psicologico, difficoltà di concentrazione, disturbi dell’umore dovuti ad una sensazione di mancanza di controllo del proprio corpo, problemi digestivi e disturbi del sonno, che in alcuni casi portano alla depressione.
Sintomi simili a quelli manifestati dai pazienti, con sindrome di Tourette denominata anche dei tic cronici, dove sono presenti anche segni motori involontari espressi sotto forma di tic, che ricorrenti cronicamente interferiranno con il normale sviluppo della vita sociale, poiché solitamente sono associati alla coprolalia, che è l’espressione di parole oscene e socialmente inappropriate, causate dalla mancanza di controllo.
Come possiamo vedere, un’alterazione del tono muscolare sarà anche un’indicazione che qualcosa non sta andando bene nel nostro corpo, sia a livello neurologico che midollare, normalmente correlato al sistema nervoso.
Così, quando questo controllo sui movimenti è “compromesso” da qualche malattia neurologica, può produrre patologia come il Parkinson o la Corea di Huntington, nota anche come Ballo di San Vito.
Per quanto riguarda i problemi di controllo muscolare, sebbene possano essere utilizzate molte classificazioni di tremori, in base ai muscoli interessati o alla funzione coinvolta, in questo libro li distingueremo tra tremori a riposo e tremori da azione.
I primi si riferiscono ai muscoli in stato di rilassamento, cioè mentre la persona rimane ferma, in piedi o seduta, senza fare nulla, e nonostante questo il paziente soffre di tremori; mentre i tremori di azione, d’altra parte, sono quelli che compaiono solo quando un’azione sta per essere eseguita, sia che si tratti di prendere un oggetto o di camminare.
Lo svantaggio di soffrire di quest’ultimo tipo di tremore è che ostacola l’azione intrapresa, ad esempio, quando si vuole portare il cibo dal piatto alla bocca, avere tremori di azione alla mano o all’avambraccio significa che il cibo viene rovesciato a causa di tali tremori.
Va ricordato che quando si esegue un’azione, ad esempio quando si flette il braccio, ci sono muscoli che si contraggono, cioè quando subiscono il tremore durante l’azione, e muscoli che rimangono rilassati, che di solito non soffrono di tremore, ma come sono correlati i tremori nel Morbo di Parkinson?
Questo è esattamente ciò che si è cercato di scoprire con una ricerca condotta dalla Parkinson’s Clinic di East Toronto e dal Centre for Movement Disorders (Canada) [6].
Lo studio ha incluso 100 pazienti con diagnosi di Morbo di Parkinson, di età compresa tra 43 e 99 anni, nei quali è stata osservata la lateralità dei tremori, sia di riposo che di azione, studiando solo i tremori delle estremità superiori, valutati utilizzando la Unified P.D. Rating Scale [7].
I risultati indicano una relazione inversa tra l’intensità del tremore a riposo e il tremore d’azione, una relazione che viene mantenuta solo sullo stesso lato del corpo.
Pertanto, la presenza di tremore moderato a riposo in un arto significa che, su quel lato del corpo, c’è una probabilità significativamente inferiore di subire un tremore d’azione.
Tremori dei muscoli che inizialmente appariranno al centro del corpo, ma che possono diffondersi anche all’altra metà, tenendo conto che, sebbene la caratteristica più eclatante sia proprio questo tremore, il Morbo di Parkinson presenta anche sintomi come la rigidità e instabilità posturale e lentezza nei movimenti.
Come è stato affermato finora, il Morbo di Parkinson è una patologia neurodegenerativa associata al controllo muscolare, quindi i suoi effetti peggioreranno con l’età.
A questo vanno aggiunti i problemi del passare del tempo, con la progressiva diminuzione dell’autonomia personale.
Questo aspetto è una delle maggiori preoccupazioni per i pazienti affetti dal Parkinson, sapendo che è una questione di tempo prima che diventino sempre più dipendenti dal fare quasi qualsiasi attività.
Va tenuto presente che i problemi muscolari associati alla malattia sono in aumento, ma esiste una relazione tra Morbo di Parkinson e problemi cognitivi?
A questo si è cercato di dare una risposta con un’indagine condotta dal Dipartimento di Neurologia, Facoltà di Medicina, Università Ondokuz Mayis; insieme alla Clinica Neurologica, Formazione e Ricerca Ospedaliera; e il servizio di neurologia, Carsamba State Hospital (Turchia) [8].
Allo studio hanno partecipato trentasette pazienti con diagnosi di Morbo di Parkinson, di età compresa tra 55 e 77 anni, di cui diciannove donne.
I partecipanti hanno compilato una scala per determinare il livello di indipendenza utilizzando le Scales for Outcomes nel Morbo di Parkinson – Automatiche [9]; le Hoehn e Yahr Scale sono state utilizzate per determinare la gravità della [10]malattia; allo stesso modo, le capacità cognitive sono state valutate utilizzando il Mini Mental State Examination test [11,12], il Blessed test [13] e il Frontal Evaluation Test [14].
La scala della depressione geriatrica è stata utilizzata per rilevare i sintomi depressivi; e infine, per valutare l’attenzione e la memoria a breve termine, è stato utilizzato un test di sequenza numerica.
I risultati riportano che non esiste una correlazione significativa tra il livello di autonomia e le capacità cognitive, funzionando in modo indipendente.
D’altra parte, esiste una correlazione negativa tra la gravità della malattia e le capacità cognitive, ovvero, maggiore è la gravità, minori sono i punteggi ottenuti nelle capacità cognitive.
Tra i limiti dello studio, va notato che, pur avendo quasi lo stesso numero di partecipanti per ogni sesso, non è stata effettuata un’analisi comparativa, quindi non è possibile fare alcuna inferenza al riguardo in base al genere.
Allo stesso modo, la gamma dei partecipanti è molto ampia e gli effetti dell’età possono essere confusi, quindi sarebbe bene se fossero stati separati in due gruppi, ad esempio sotto e sopra i 65 anni, per verificare se ci sono differenze, che potrebbero essere spiegate solo dall’età.
Читать дальше