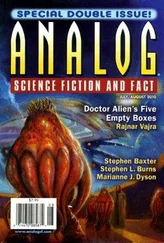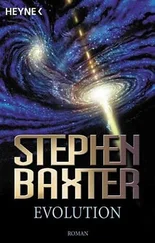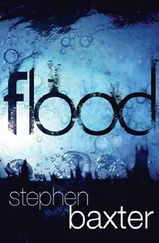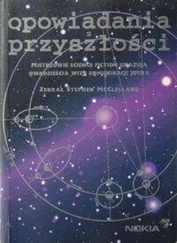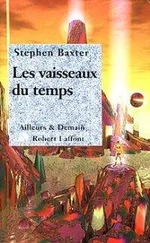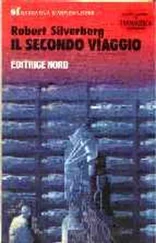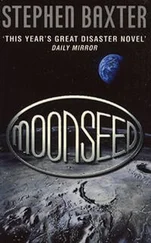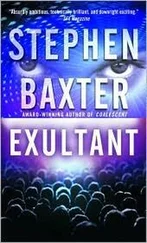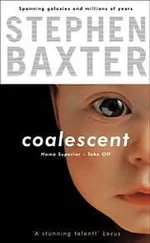Abbandonata la vettura temporale, tomai da Nebogipfel: — È finita! — gridai. — Dobbiamo andarcene da qui!
— Ma la macchina…
— Dobbiamo abbandonarla! Non vedi? Se continua così, l’inondazione ci travolgerà, gettandoci in mare!
Con le ciocche di pelliccia che pendevano come cenci fradici, Nebogipfel si alzò a fatica. Cercò di liberarsi dalla mia presa, quando lo afferrai, e forse, se non avesse avuto la gamba rotta, ci sarebbe riuscito.
— Non posso salvarla! — gli urlai in faccia, trattenendolo. — Saremo fortunati se riusciremo a salvare la stramaledetta pelle! — Ciò detto, me lo caricai in spalla e, allontanandomi dai resti della capanna, m’incamminai verso la foresta.
Subito mi trovai a procedere a guado in parecchi centimetri d’acqua fredda e fangosa. Più di una volta scivolai sulla sabbia viscida, senza però lasciare il Morlock che si dibatteva nella stretta del mio braccio.
Nella foresta, la pioggia, intercettata dalle chiome degli alberi, era Più rada. Proseguii il cammino nell’oscurità assoluta, inciampando nelle radici sporgenti, sbattendo contro i fusti, scivolando sul suolo fradicio e infido. Intanto, Nebogipfel si abbandonò immoto sulle mie spalle, rinunciando a dibattersi.
Finalmente, giunsi a un albero che mi sembrava di ricordare: era antico, con il fusto enorme, e i rami più bassi a un’altezza di poco superiore alla mia. Posai sopra un ramo Nebogipfel, che vi si aggrappò come una giacca inzuppata. Con un certo sforzo, giacché era ormai da molto tempo che non mi dedicavo più a quell’esercizio, mi arrampicai a mia volta su un ramo, dove rimasi seduto, addossato al tronco.
Rimanemmo là in attesa che la tempesta cessasse. Io tenni una mano posata sulla schiena di Nebogipfel, per assicurarmi che non cadesse o che non cercasse di tornare alla macchina. Nel frattempo fui costretto a sopportare l’acqua che, ruscellando giù lungo il tronco, m’investiva le spalle e la schiena.
L’appressarsi dell’alba conferì una bellezza sovrannaturale alla foresta. Scrutando le chiome, vidi la pioggia gocciolare dalle foglie, le cui forme si erano evolute anche per assolvere a quella funzione, e scorrere giù lungo i fusti. Non sono granché come botanico, però in quel momento compresi che la foresta era simile a una macchina immensa, progettata per sopravvivere, anche agli assalti delle tempeste, di gran lunga meglio di quanto lo fossero le rozze costruzioni umane.
Mentre la luce si diffondeva, strappai una striscia da ciò che restava dei miei calzoni (non avevo più camicie), poi, mentre Nebogipfel restava immobile, gliela legai sul viso per proteggergli l’occhio.
Spiovve a mezzogiorno. Allora giudicai che non vi fosse più alcun pericolo a scendere dall’albero. Aiutai Nebogipfel a smontare dal ramo: era in grado di camminare, però era del tutto cieco, senza gli occhiali, quindi fui costretto a tenerlo per mano, per guidarlo.
Era una giornata luminosa e fresca. Dal mare spirava una brezza gradevole, e nuvole lievi correvano in un cielo quasi inglese. Sembrava che il mondo fosse stato ricreato: nulla restava dell’atmosfera opprimente del giorno precedente.
Con una certa riluttanza mi avvicinai alla capanna, perché fra i resti semisepolti nella sabbia bagnata, inclusi gli oggetti, come i recipienti e gli attrezzi, razzolava con il becco enorme e goffo un pulcino di Diatryma. Gridando e battendo le mani sopra la testa, avanzai di corsa. L’uccello scappò, con la pelle gialla e floscia delle zampe che oscillava.
Frugai nello sfacelo, constatando che ciò che ci era appartenuto era stato in gran parte spazzato via dall’inondazione. La capanna era stata piccola e fragile, i nostri pochi oggetti erano stati ricavati alla meglio dai materiali fomiti dalla natura e dalla vettura temporale, eppure provai una sconcertante impressione di profanazione e di spoliazione, perché si era trattato della nostra casa e dei nostri effetti personali.
— E la macchina? — chiese Nebogipfel, cieco, volgendo il viso qua e là. — Che cosa è successo alla vettura temporale?
Con una breve ricerca, disseppellii qualche nervatura, qualche tubo e qualche lamiera, più storti e più danneggiati di prima. Il resto dell’apparecchio, però, era stato portato in mare.
Ad occhi chiusi, palpando i rottami, Nebogipfel commentò: — Be’, dovrà bastare… — Seduto sulla sabbia, cercò a tastoni pezzi di tessuto e di fili, per cominciare pazientemente a ricostruire ancora una volta la macchina del tempo.
Dopo la tempesta, non riuscimmo mai a ritrovare gli occhiali, di conseguenza Nebogipfel si trovò in grave svantaggio. In ogni modo, non si lamentò. Come aveva sempre fatto in precedenza, durante il giorno rimase all’ombra, e se per qualche ragione fu costretto ad esporsi alla luce del crepuscolo o dell’alba, indossò l’ampio cappello, nonché una specie di maschera di pelle con due fessure per gli occhi, che gli avevo confezionato appositamente, in maniera che potesse vedere pur avendo la vista protetta.
La tempesta non mi turbò soltanto fisicamente, bensì anche mentalmente, perché in precedenza avevo cominciato a convincermi di essere in grado di proteggermi da tutte le calamità con cui il mondo primitivo avrebbe potuto aggredirmi. Decisi dunque che occorreva garantire maggiore sicurezza alle nostre vite. Dopo qualche riflessione, giudicai che la prima necessità fosse una solida palafitta, in grado di salvarsi dalle inondazioni provocate in futuro dai monsoni. Però, sia per l’irregolarità delle loro forme, sia perché talvolta erano marcescenti, non potevo servirmi dei rami caduti. Mi occorrevano tronchi d’albero, ma per procurarmeli avevo bisogno di una scure.
Così, trasformandomi per qualche tempo in un geologo dilettante, mi misi alla ricerca di formazioni rocciose adeguate. Finalmente, in uno strato ghiaioso nella zona di Hampstead Heath, che mi sembrò il deposito alluvionale di qualche fiume ormai scomparso, trovai alcune selci, fosche e arrotondate, insieme a un po’ di calcedonia.
Trasportai al nostro accampamento quei tesori con la massima cura, come se si trattasse d’oro: anzi, con maggior cura ancora, perché una quantità equivalente di oro non avrebbe avuto alcun valore, per me.
Sulla spiaggia, dopo parecchi esperimenti e uno spreco considerevole di materiale, imparai come spaccare la selce lungo le venature e come affilarla. Nel lavorare, mi sentivo goffo e inesperto. Avevo sempre osservato con grande meraviglia le punte di freccia e le lame di scure esposte nelle bacheche dei musei, ma soltanto dopo avere provato personalmente a fabbricarle mi resi conto di quale abilità e quale intuizione tecnica avessero posseduto i nostri progenitori dell’età della pietra.
Finalmente, riuscii a fabbricare una lama che mi soddisfacesse. Servendomi di strisce di pelle, la fissai a un corto manico di legno ricavato da un ramo, quindi m’incamminai, entusiasta, verso la foresta.
Meno di un quarto d’ora più tardi tornai con la scure spezzata: si era spaccata al secondo colpo, scalfendo a malapena la corteccia dell’albero che avevo scelto.
In seguito a un altro breve periodo di sperimentazione, tuttavia, riuscii a fabbricare una scure adeguata, che mi consentì di abbattere alcuni alberelli diritti.
Scelsi per la nuova capanna un luogo presso la spiaggia, inaccessibile all’alta marea e ai possibili straripamenti del ruscello. Impiegai parecchio tempo a scavare fondamenta abbastanza profonde, ma alla fine costruii una solida palafitta, alta circa un metro. La piattaforma era tutt’altro che piana, ma mi proponevo d’imparare a costruire tavole decenti, prima o poi. Comunque, allorché mi ci coricai, la sera, essa mi parve sicura, tale da porre me e il mio compagno al riparo dai pericoli del suolo. Quasi desiderai che un’altra tempesta si abbattesse su di noi, per mettere alla prova la mia nuova creazione.
Читать дальше